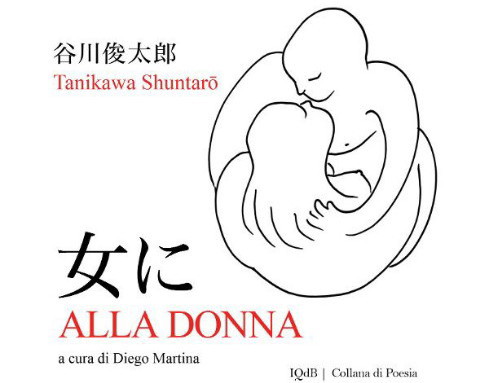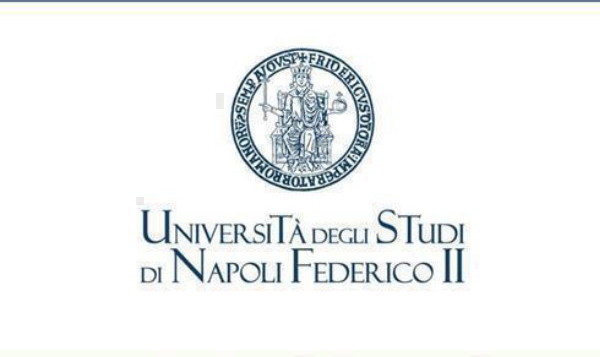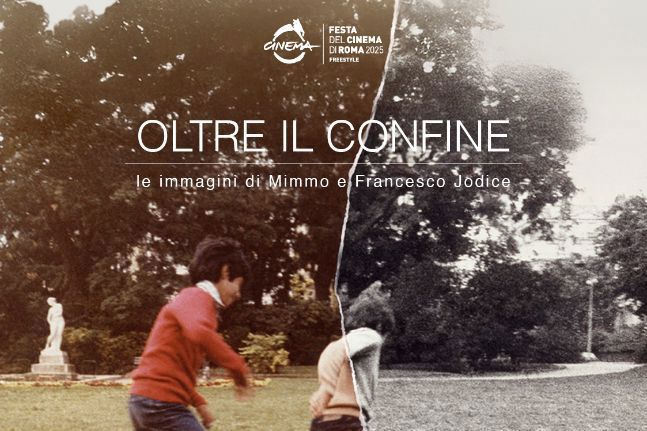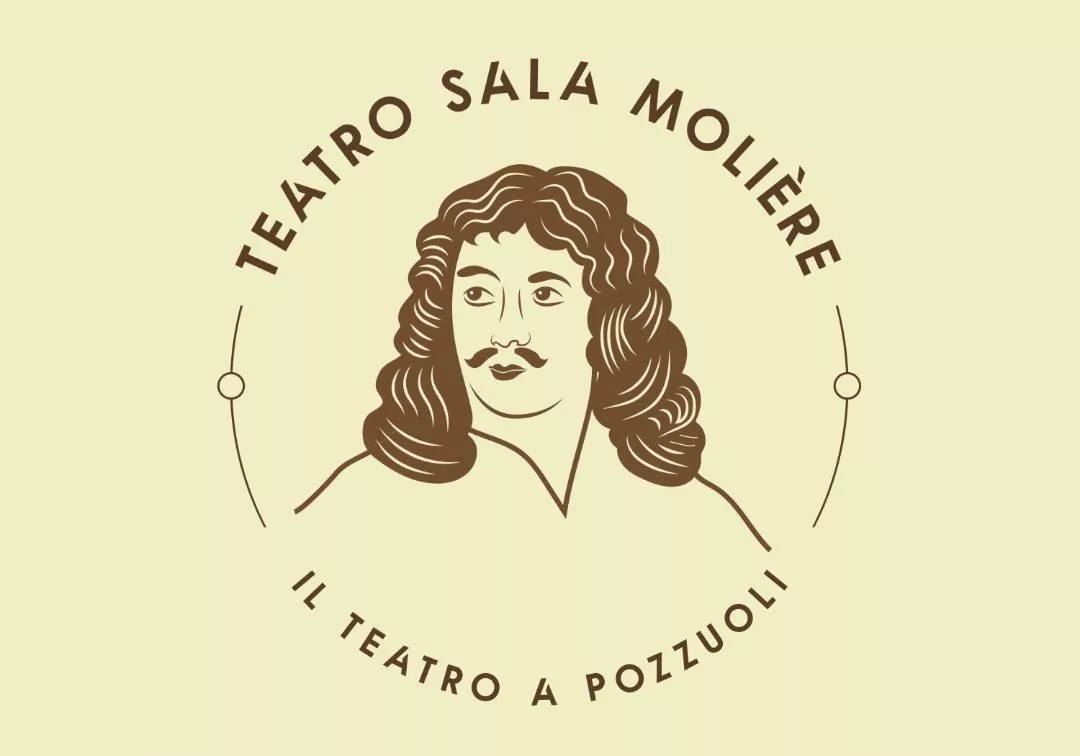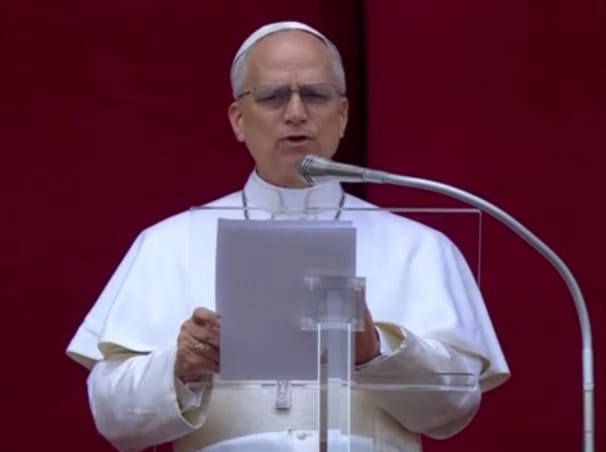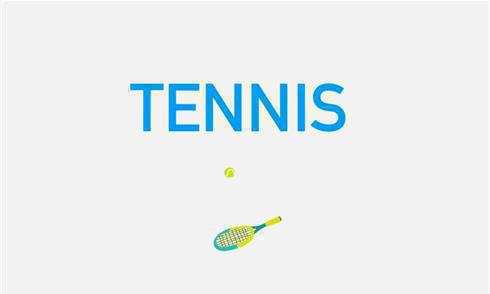“Un ballo in maschera” di Giuseppe Verdi, capolavoro di espressione pura, di semplice rappresentazione fantastica, ha segnato l’inizio d’ottobre del teatro San Carlo. Non bisogna pensare alla grande storia attraverso Gustavo III di Svezia, i vari rifacimenti per le censure, sino al Riccardo, Conte di Warwick, governatore di Boston, ma ad un accadimento di varia umanità: due che si vogliono bene, ma lei è sposata, per di più al migliore e devoto amico di lui, che è governatore. Arrivano fino a perdere la testa in un’avvampante dichiarazione, lui, e di un pudico aveu d’amour, lei, poi vengono scoperti, lui cadrà sotto il pugnale dell’amico che si è unito ai congiurati, ma sopravvivrà quel tanto che basta per perdonare tutti e assicurare che Amelia è pura.
Vita quotidiana, quindi, “universale”, senza pesanti griglie culturali e valida entro qualunque background sociopolitico, storico o geografico. La caratteristica del Ballo verdiano è la cordialità, l’affetto. Sebbene finisca tragicamente, ha tono di commedia e, in qualche modo, si sottrae al torvo pessimismo, all’ineluttabilità del Destino, che è il fil rouge delle opere del genio italiano. Il male, qui, non è alla radice delle cose, è un’eccezione sciagurata. I cattivi sono solo due Sam e Tom e, talmente emarginati, che si esprimono con un contrappunto grottesco e scolastico. Un’ idea di regia scontata, fissa, quella di Massimo Pizzi Gasparon Contarini, cognome altisonante il suo, con il famoso padre che è intervenuto alla recita del 5 ottobre, rimasta ferma a quarant’anni fa, quando in effetti è nata, con fondali vetusti, ispirata a certa pittura fiamminga, che, attenzione pur giocava con la luce, con l’antro di Ulrica e le scene dell’ultimo atto, il ballo, ravvivate, per quanto possa dirsi, dalle coreografie di Gino Potente, interpretate dagli allievi della Scuola di Ballo del massimo partenopeo diretta da Clotilde Vayer.
Tutto affidato all’interpretazione attoriale dei cantanti, ai colori degli abiti, a qualche simbolo, quale la doppia maschera per le danze finali, ma nessuna pennellata di vernice fresca sopra, ormai, polverosi cimeli. Non possiamo non inquadrare questa produzione, allora, se non seguendo l’onda musicale della veramente “svecchiata” orchestra, guidata dall’esperta bacchetta di Pinchas Steinberg, il quale è riuscito a sviluppare la qualità sinfonica implicita nella partitura verdiana, e dei cantanti, con l’iperbole schizzata dal bel tenore napoletano Vincenzo Costanzo, il cui picco è risultato la ballata cantata nell’antro di Ulrica. La voce è molto bella, un dono, questo, di una schiettezza contagiosa. È altamente spontanea, ma anche ben impostata, con giusta proiezione, buon sostegno del fiato e passaggi adeguati.
È stata la voce di Riccardo. Costanzo la ha usata con esuberanza controllata nel primo atto, senza affievolirla. La vitalità gli ha permesso gesti vocali marcati, come nel “La rivedrò nell’estasi”, con estroversione e cantabilità generosa. Non è mancata la morbidezza richiesta da Verdi, ed è stato in grado di equilibrare l’eufonia con una sincerità generale, evitando, anche un’eleganza troppo ricercata, che avrebbe rischiato l’affettazione. In questo modo il canto è risultato moderno, pur guardando al nostro luminoso passato, capace di regalare immediatezza e piacere al pubblico. L’invito alla “magion d’Ulrica” cambia in brio, quindi, si è ammirata l’espansione della voce nel fortissimo del Terzetto, che precede la ripresa di “Ardo, e seguirla ho fisso” e la ballata, “Di tu se’ fedele”, in cui Costanzo non ha disdegnato di ammiccare al pescatore napoletano, intonata per celia, ma subito pronta a farsi seria, è risultata ampia, con contrasti di luce e ombra, con il ricercato attacco della seconda strofa dal tono misterioso e affabulatorio, sino allo scintillante finale.
La voce, capace di riempire sale grandi, ha permesso a Costanzo di affrontare l’aria del III atto senza problemi, contrariamente ad alcuni tenori legittimamente criticati come non adatti a certe tessiture, che soffrono, non essendo questa, parte per tenore lirico né tanto meno per tenore lirico leggero. Dopo un recitativo teatralmente partecipato, Costanzo ha attaccato “Ma se m’è forza perderti” con espressione, senza difficoltà con la tessitura. Da qui la forza di “nell’intimo del cor” e di “Ed or”, in “come se fosse l’ultima”, in cui il legato sostiene la linea melodica, soprattutto, quando la voce sale al si bemolle. Si è quindi, giunti alla chiusura della scena, in cui la prova dei grandi momenti vocali si intensifica, e nel finale la voce è restata brillante e coinvolgente. Ci sono stati altre parentesi di fraseggio intenso ad esempio, nel duettino con Amelia, dove Costanzo ha dominato la scena, con presenza sia vocale che scenica forte e credibile.
Si arriva così alla morte di Riccardo, considerata “bella” per un tenore romantico, piena di cantabilità, grandiosa, lui, appassionato nel saluto finale, “Addio per sempre miei figli…”, strappapplausi. Altro talento campano, stavolta salernitano, è Ernesto Petti, che ha offerto la sua voce a Renato, il segretario creolo di Riccardo. Il baritono verdiano, è noto, ha doppia natura, esordisce in zona luminosa, ma la sua costante consapevolezza di una minaccia occulta getta sin dall’inizio un’ombra sulla sua parte. La qualità del nostro baritono è venuta fuori nell’aria “Eri tu”, in cui si sposta nella zona dell’oscurità e guarda indietro con nostalgia verso la luce, la chiave del dramma, accolto da applausi convinti, con cui ha dimostrato una padronanza assoluta dello strumento, tratteggiando un Renato dal portamento nobile. La linea di canto, emissione morbida e mai forzata né esagerata è apparsa fluida ed elegante. Ottimo controllo del fiato, fraseggio accurato e buona tecnica uniti a doti comunicative, fanno di lui uno delle voci di baritono a cui affidarsi in scena oggi. Nota dolente, l’Amelia di Oksana Dika: ciò che è arrivato sono stati solo suoni freddi e taglienti, il registro centrale potrebbe andare per altri ruoli, ma nell’estremo è mancato un buon fraseggio: i suoni non sono risultati “cantati”, ma disgiunti, metallici e stridenti, e le frasi si sono, così, ridotte ad emissioni fisse e aspre, che il pubblico non ha perdonato “buhando” la celebre aria, “Morrò, ma prima in grazia”, introdotta dal violoncello obbligato, il cui suono, all’ “italiana” struggente, quanto la coda della pagina in sesta napoletana, con l’arco scuro di rinforzo è stato quello di Alberto Senatore. Bene, invece, la Ulrica della Elizabeth De Shong, la quale ha mantenuto una presenza scenica solida, imponendosi con un timbro autenticamente mezzosopranile e versatilmente impiegabile.
L’invocazione “Re dell’abisso affrettati” è apparsa centrata e inquietante, così come gli ensemble successivi con le altre voci. Cassandre Berthon è risultata deliziosa e spiritosa nel ruolo en travesti di Oscar, impeccabile nelle note puntate, nelle fioriture e nelle agilità, brillando in “Volta la terrea”, incisiva nell’attacco del quintetto “Di che fulgor, che musiche” e divertente nel “Saper vorreste”, proiezione stessa di Riccardo, nonché retaggio dell’influenza francese del giovane Verdi. A completare il cast degne voci, quali Romano Dal Zovo Samuel, Adriano Gramigni Tom e Maurizio Bove, in quello di Silvano.
Un deciso plauso va al coro diretto da Fabrizio Cassi, personaggio, anch’esso, e su tutti ad una ringiovanita orchestra, a cominciare dalla sezione degli ottoni, per i quali non possiamo non citare la prima tromba, per il suo splendido solo, che è l’esperto Giuseppe Cascone, con al suo fianco Ruben Covelli, i tromboni con Camilli e Toteda, Pignotti, Pietrantoni e il giovanissimo Pennisi, che andrà a parlar fiorentino. Poi, ci sono i “senatori” del golfo mistico: il suono inconfondibile del flauto di Bernard Labiausse, sua la ripresa della preghiera intonata nel terzetto sul tremolo degli archi, la mazurka dell’ultimo atto guidata dal Konzertmeister Gabriele Pieranunzi, e i legni tutti, i suoni del “ricordo” di oboe e corno inglese Gareffa e Cutrona, quest’ultimo protagonista nel “Ma dall’arido stelo divulsa”, il ritorno in grande spolvero di Franco Cardaropoli ai piatti e la assoluta magia dei timpani di Guillem Brichs Ruiz, i quali hanno permesso al direttore di sovrapporsi come le immagini di un mirino fotografico perfettamente a fuoco, in buca, ottenendo la collaborazione e compenetrazione incessante delle masse orchestrali e corali. Nelle varie chiamate al proscenio, la vincono le voci maschili di Vincenzo Costanzo su tutti e di Ernesto Petti, unitamente a Elizabeth De Shong e Cassandre Berthon.

di Napoli Magazine
14/10/2025 - 10:19
“Un ballo in maschera” di Giuseppe Verdi, capolavoro di espressione pura, di semplice rappresentazione fantastica, ha segnato l’inizio d’ottobre del teatro San Carlo. Non bisogna pensare alla grande storia attraverso Gustavo III di Svezia, i vari rifacimenti per le censure, sino al Riccardo, Conte di Warwick, governatore di Boston, ma ad un accadimento di varia umanità: due che si vogliono bene, ma lei è sposata, per di più al migliore e devoto amico di lui, che è governatore. Arrivano fino a perdere la testa in un’avvampante dichiarazione, lui, e di un pudico aveu d’amour, lei, poi vengono scoperti, lui cadrà sotto il pugnale dell’amico che si è unito ai congiurati, ma sopravvivrà quel tanto che basta per perdonare tutti e assicurare che Amelia è pura.
Vita quotidiana, quindi, “universale”, senza pesanti griglie culturali e valida entro qualunque background sociopolitico, storico o geografico. La caratteristica del Ballo verdiano è la cordialità, l’affetto. Sebbene finisca tragicamente, ha tono di commedia e, in qualche modo, si sottrae al torvo pessimismo, all’ineluttabilità del Destino, che è il fil rouge delle opere del genio italiano. Il male, qui, non è alla radice delle cose, è un’eccezione sciagurata. I cattivi sono solo due Sam e Tom e, talmente emarginati, che si esprimono con un contrappunto grottesco e scolastico. Un’ idea di regia scontata, fissa, quella di Massimo Pizzi Gasparon Contarini, cognome altisonante il suo, con il famoso padre che è intervenuto alla recita del 5 ottobre, rimasta ferma a quarant’anni fa, quando in effetti è nata, con fondali vetusti, ispirata a certa pittura fiamminga, che, attenzione pur giocava con la luce, con l’antro di Ulrica e le scene dell’ultimo atto, il ballo, ravvivate, per quanto possa dirsi, dalle coreografie di Gino Potente, interpretate dagli allievi della Scuola di Ballo del massimo partenopeo diretta da Clotilde Vayer.
Tutto affidato all’interpretazione attoriale dei cantanti, ai colori degli abiti, a qualche simbolo, quale la doppia maschera per le danze finali, ma nessuna pennellata di vernice fresca sopra, ormai, polverosi cimeli. Non possiamo non inquadrare questa produzione, allora, se non seguendo l’onda musicale della veramente “svecchiata” orchestra, guidata dall’esperta bacchetta di Pinchas Steinberg, il quale è riuscito a sviluppare la qualità sinfonica implicita nella partitura verdiana, e dei cantanti, con l’iperbole schizzata dal bel tenore napoletano Vincenzo Costanzo, il cui picco è risultato la ballata cantata nell’antro di Ulrica. La voce è molto bella, un dono, questo, di una schiettezza contagiosa. È altamente spontanea, ma anche ben impostata, con giusta proiezione, buon sostegno del fiato e passaggi adeguati.
È stata la voce di Riccardo. Costanzo la ha usata con esuberanza controllata nel primo atto, senza affievolirla. La vitalità gli ha permesso gesti vocali marcati, come nel “La rivedrò nell’estasi”, con estroversione e cantabilità generosa. Non è mancata la morbidezza richiesta da Verdi, ed è stato in grado di equilibrare l’eufonia con una sincerità generale, evitando, anche un’eleganza troppo ricercata, che avrebbe rischiato l’affettazione. In questo modo il canto è risultato moderno, pur guardando al nostro luminoso passato, capace di regalare immediatezza e piacere al pubblico. L’invito alla “magion d’Ulrica” cambia in brio, quindi, si è ammirata l’espansione della voce nel fortissimo del Terzetto, che precede la ripresa di “Ardo, e seguirla ho fisso” e la ballata, “Di tu se’ fedele”, in cui Costanzo non ha disdegnato di ammiccare al pescatore napoletano, intonata per celia, ma subito pronta a farsi seria, è risultata ampia, con contrasti di luce e ombra, con il ricercato attacco della seconda strofa dal tono misterioso e affabulatorio, sino allo scintillante finale.
La voce, capace di riempire sale grandi, ha permesso a Costanzo di affrontare l’aria del III atto senza problemi, contrariamente ad alcuni tenori legittimamente criticati come non adatti a certe tessiture, che soffrono, non essendo questa, parte per tenore lirico né tanto meno per tenore lirico leggero. Dopo un recitativo teatralmente partecipato, Costanzo ha attaccato “Ma se m’è forza perderti” con espressione, senza difficoltà con la tessitura. Da qui la forza di “nell’intimo del cor” e di “Ed or”, in “come se fosse l’ultima”, in cui il legato sostiene la linea melodica, soprattutto, quando la voce sale al si bemolle. Si è quindi, giunti alla chiusura della scena, in cui la prova dei grandi momenti vocali si intensifica, e nel finale la voce è restata brillante e coinvolgente. Ci sono stati altre parentesi di fraseggio intenso ad esempio, nel duettino con Amelia, dove Costanzo ha dominato la scena, con presenza sia vocale che scenica forte e credibile.
Si arriva così alla morte di Riccardo, considerata “bella” per un tenore romantico, piena di cantabilità, grandiosa, lui, appassionato nel saluto finale, “Addio per sempre miei figli…”, strappapplausi. Altro talento campano, stavolta salernitano, è Ernesto Petti, che ha offerto la sua voce a Renato, il segretario creolo di Riccardo. Il baritono verdiano, è noto, ha doppia natura, esordisce in zona luminosa, ma la sua costante consapevolezza di una minaccia occulta getta sin dall’inizio un’ombra sulla sua parte. La qualità del nostro baritono è venuta fuori nell’aria “Eri tu”, in cui si sposta nella zona dell’oscurità e guarda indietro con nostalgia verso la luce, la chiave del dramma, accolto da applausi convinti, con cui ha dimostrato una padronanza assoluta dello strumento, tratteggiando un Renato dal portamento nobile. La linea di canto, emissione morbida e mai forzata né esagerata è apparsa fluida ed elegante. Ottimo controllo del fiato, fraseggio accurato e buona tecnica uniti a doti comunicative, fanno di lui uno delle voci di baritono a cui affidarsi in scena oggi. Nota dolente, l’Amelia di Oksana Dika: ciò che è arrivato sono stati solo suoni freddi e taglienti, il registro centrale potrebbe andare per altri ruoli, ma nell’estremo è mancato un buon fraseggio: i suoni non sono risultati “cantati”, ma disgiunti, metallici e stridenti, e le frasi si sono, così, ridotte ad emissioni fisse e aspre, che il pubblico non ha perdonato “buhando” la celebre aria, “Morrò, ma prima in grazia”, introdotta dal violoncello obbligato, il cui suono, all’ “italiana” struggente, quanto la coda della pagina in sesta napoletana, con l’arco scuro di rinforzo è stato quello di Alberto Senatore. Bene, invece, la Ulrica della Elizabeth De Shong, la quale ha mantenuto una presenza scenica solida, imponendosi con un timbro autenticamente mezzosopranile e versatilmente impiegabile.
L’invocazione “Re dell’abisso affrettati” è apparsa centrata e inquietante, così come gli ensemble successivi con le altre voci. Cassandre Berthon è risultata deliziosa e spiritosa nel ruolo en travesti di Oscar, impeccabile nelle note puntate, nelle fioriture e nelle agilità, brillando in “Volta la terrea”, incisiva nell’attacco del quintetto “Di che fulgor, che musiche” e divertente nel “Saper vorreste”, proiezione stessa di Riccardo, nonché retaggio dell’influenza francese del giovane Verdi. A completare il cast degne voci, quali Romano Dal Zovo Samuel, Adriano Gramigni Tom e Maurizio Bove, in quello di Silvano.
Un deciso plauso va al coro diretto da Fabrizio Cassi, personaggio, anch’esso, e su tutti ad una ringiovanita orchestra, a cominciare dalla sezione degli ottoni, per i quali non possiamo non citare la prima tromba, per il suo splendido solo, che è l’esperto Giuseppe Cascone, con al suo fianco Ruben Covelli, i tromboni con Camilli e Toteda, Pignotti, Pietrantoni e il giovanissimo Pennisi, che andrà a parlar fiorentino. Poi, ci sono i “senatori” del golfo mistico: il suono inconfondibile del flauto di Bernard Labiausse, sua la ripresa della preghiera intonata nel terzetto sul tremolo degli archi, la mazurka dell’ultimo atto guidata dal Konzertmeister Gabriele Pieranunzi, e i legni tutti, i suoni del “ricordo” di oboe e corno inglese Gareffa e Cutrona, quest’ultimo protagonista nel “Ma dall’arido stelo divulsa”, il ritorno in grande spolvero di Franco Cardaropoli ai piatti e la assoluta magia dei timpani di Guillem Brichs Ruiz, i quali hanno permesso al direttore di sovrapporsi come le immagini di un mirino fotografico perfettamente a fuoco, in buca, ottenendo la collaborazione e compenetrazione incessante delle masse orchestrali e corali. Nelle varie chiamate al proscenio, la vincono le voci maschili di Vincenzo Costanzo su tutti e di Ernesto Petti, unitamente a Elizabeth De Shong e Cassandre Berthon.